Parte da una domanda retorica il saggio di Dario Giardi E se fosse la musica a salvarci? La memoria dei suoni e la sfida climatica uscito per Mimesis edizioni lo scorso maggio. Il libro prova ad approfondire le connessioni e le influenze tra la musica e i suoni con l’ecologia e la crisi climatica.
La crisi climatica, tra i molteplici effetti che ha avuto e ha sugli esseri umani, ha modificato in maniera profonda il rapporto con il suono, il rumore e l’ascolto, trasformando il paesaggio sonoro di molti luoghi naturali.
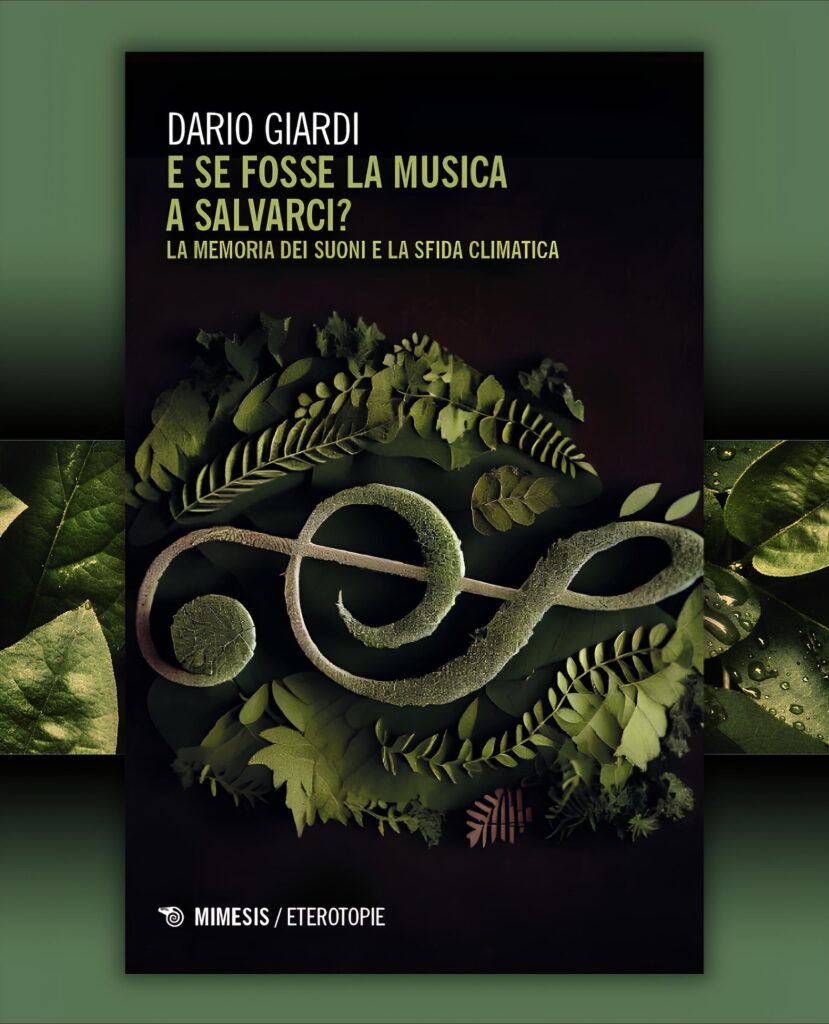
Perciò, secondo Giardi, la musica potrebbe essere un linguaggio e uno strumento che può aiutare a riconnettersi all’ambiente e a recuperare la sensibilità ecologica. Da questo spunto parte la nostra intervista all’autore.
Giardi, in che modo la musica può risvegliare la nostra coscienza ambientale e come si intrecciano musica ed ecologia?
La musica non è solo un linguaggio estetico, ma un dispositivo di ascolto e di consapevolezza. Nella sua dimensione profonda ci mette in risonanza con ciò che ci circonda, ricordandoci che non siamo entità isolate ma parte di un ecosistema complesso.
Ascoltare significa imparare a riconoscere le relazioni invisibili che ci legano alla natura: il ritmo delle stagioni, il rumore del vento, il respiro del mare.
La musica, quando non è ridotta a mero intrattenimento, può diventare una pratica ecologica, un atto politico e poetico insieme, perché ci restituisce un senso di appartenenza alla Terra e ci ricorda che la sua salute è intimamente connessa alla nostra.
Nel libro viene coniato il termine memoryscape, che significato ha?
Il memoryscape è un paesaggio della memoria, un intreccio di suoni, ricordi ed emozioni che ci radicano a un luogo.
Ogni persona porta dentro di sé una geografia sonora che lo lega all’infanzia, ai luoghi vissuti, agli incontri quotidiani con la natura.
Questo concetto unisce la dimensione individuale della memoria con quella collettiva dei paesaggi sonori, suggerendo che la salvaguardia dell’ambiente non è soltanto un fatto tecnico o scientifico, ma anche una questione culturale ed emotiva.
Proteggere i paesaggi naturali significa preservare i memoryscape che danno forma alla nostra identità.
Come si sta trasformando, anche a causa della crisi climatica, il nostro rapporto con il suono e con l’ambiente circostante?
Il cambiamento climatico sta alterando non solo gli equilibri ecologici, ma anche le sonorità del mondo.
Specie animali che scompaiono, ecosistemi che si degradano, silenzi che si fanno più profondi o rumori che diventano assordanti: tutto questo modifica i paesaggi sonori ai quali eravamo abituati.
L’orecchio umano si trova così esposto a un ambiente che ci appare sempre più fragile e minacciato. Questa trasformazione può generare smarrimento, ma anche un’opportunità: imparare a sviluppare un ascolto più attento, capace di riconoscere i segnali della crisi e di tradurli in nuove forme di responsabilità e cura.
La musica può essere un mezzo per trasformare il nostro rapporto con la natura? In quale modo può farlo?
Sì, la musica può essere una soglia per ricostruire il legame con la natura. Non lo fa attraverso discorsi razionali, ma grazie alla sua capacità di evocare, emozionare, generare empatia. Un brano che integra suoni della natura, un’esperienza di ascolto immersivo o una composizione che nasce dal dialogo con l’ambiente possono farci percepire la Terra non come sfondo muto, ma come protagonista viva della nostra esistenza.
La musica ci ricorda che la natura non è un oggetto da sfruttare, bensì un interlocutore con cui costruire una relazione di reciprocità. In questo senso può educare, sensibilizzare e persino guidare nuove forme di comportamento ecologico.

